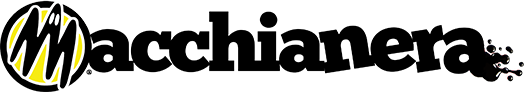Sbugiardare Marco Travaglio avrebbe bisogno di un impiego a tempo pieno, anche perché la sua specialità sono senz’altro le balle più sonore – che nessuno in genere verifica – ma soprattutto le sapienti omissioni. Nei giorni scorsi né è stato esempio spettacolare la maniera in cui ha sintetizzato l’autunno del 1994 (quando Antonio Di Pietro si dimise dalla magistratura) a uso e consumo del blog di Beppe Grillo e poi di voglioscendere e probabilmente non solo quelli, visto che ogni intervento di Travaglio viene riciclato altre cinque o sei volte tra giornali, libri, video, dvd, altri libri, altri articoli e ovviamente monologhi ad Annozero.
Nel suo intervento, comunque, il ventriloquo di Di Pietro si è rivolto al suo pubblico di ragazzetti e ha propinato loro delle gradevoli menzogne: roba che è stata la stessa magistratura – supremo totem travagliesco – ad aver già sbugiardato in maniera definitiva.
Facciano qualche esempio, davvero pochi tra mille.
Travaglio a un certo punto parla dell’imprenditore Giancarlo Gorrini e dei famosi «prestiti» (soldi & Mercedes) che Di Pietro ricevette da questo ricco imprenditore che, anche se Travaglio ovviamente non lo dice, a quel tempo era già un amicone di Di Pietro per quanto fosse inquisito per bancarotta fraudolenta nonché condannato per appropriazione indebita.
Travaglio la mette così:
«Un certo Rocca aveva aiutato Di Pietro in un momento di difficoltà prestandogli 100 milioni di lire che poi Di Pietro aveva restituito dopo l’inizio di Mani pulite… Questo risulta anche dai processi che si sono celebrati a Brescia: si stabilirà che quei soldi erano semplicemente i prestiti del suo amico Rocca, neanche di Gorrini».
Non una sola cosa vera. A parte che Di Pietro non è praticamente mai stato processato (le inchieste si fermarono tutte in udienza preliminare, 27 accuse divise in 54 procedimenti, un record insuperato) quello che è accaduto realmente è immortalato in un giudizio di tribunale dove Di Pietro figurava come parte lesa: trattasi della sentenza n.65/1997 del 29 gennaio 1997 (depositata il 10 marzo successivo, presidente Francesco Maddalo, giudice estensore Michele Mocciola) a margine dell’unico rinvio a giudizio mai andato in porto tra quelli richiesti nel 1996 dai pm Fabio Salamone e Silvio Bonfigli, e dove Cesare Previti, Paolo Berlusconi e gli ispettori ministeriali Ugo Dinacci e Domenico De Biase furono invece accusati di averlo ricattato per farlo dimettere dalla magistratura.
Il processo, durato dal 23 settembre 1996 al 18 gennaio 1997, fu condotto perlopiù sulla base delle stesse carte e testimonianze accumulate nelle inchieste di Salamone e Bonfigli già cassate in precedenza, e gli imputati furono assolti al termine di un dibattimento dove Di Pietro peraltro rifiutò di rispondere alle domande. Trattandosi di un giudizio di Tribunale che ha fatto seguito a un pubblico dibattimento con esibizione di prove e audizione di parti, dunque, la valutazione dei fatti trattati è perciò da ritenersi definitiva e vincolante rispetto a qualsiasi precedente udienza preliminare a porte chiuse: la sentenza, come si dice, «fa stato quanto ai fatti accertati», cioè è definitiva anche perché nessuna delle parti ha mai presentato appello, Di Pietro compreso.
Ebbene: di questa fondamentale sentenza, depositata dal giudice Francesco Maddalo il 10 marzo 1997, Di Pietro non ha parlato nè parla assolutamente mai. Nessuno dei giornalisti tra i tanti a lui notoriamente legati ha mai riportato, delle sue 192 pagine, una sola riga. Figurarsi Travaglio.
Nel ridondante blog di Antonio Di Pietro (http://www.antoniodipietro.com) il capitolo «La mia storia attraverso le sentenze» non menziona neppure la più importante sentenza di tribunale che lo riguarda come parte lesa, cioè questa, appunto. Tutte le vicende vengono liquidate così:
«Una miriade di accuse poi tutte smontate dai giudici “perché il fatto non sussiste”. Alla fine ho avuto giustizia, ma quelle accuse furono prese e rilanciate da altri che avevano interesse a costruirmi addosso una montagna di nefandezze che non avevo commesso».
Le «nefandezze», in realtà, benché ritenute penalmente irrilevanti, sono state storicamente acclarate proprio dalla Magistratura, e sono state commesse. Ma il perfetto dipietrista, a quanto pare, non ha motivo di saperlo nè di conoscerne i particolari. Garantisce Travaglio.
Ecco, a proposito: come diceva Travaglio? Diceva così:
«A Brescia si stabilirà che quei 100 milioni erano semplicemente i prestiti del suo amico Rocca, neanche di Gorrini».
Diceva questo. In realtà a Brescia, come alle pagine 140, 141 e 142 della citata sentenza, fu stabilito quest’altro:
«Di Pietro ammette di aver usufruito del prestito di cento milioni… fu reso edotto dell’identità dell’erogatore del prestito (Gorrini, nda) quanto meno sin dal 1992. E’ Di Pietro stesso a dirlo: “Io ho avuto modo di parlare con Gorrini della vicenda dei 120 milioni (100 più i 20 della Mercedes) nel 1992, allorché venne a trovarmi in ufficio…” Di Pietro ebbe coscienza e consapevolezza della persona che aveva provveduto all’esborso di cento milioni fin dall’inizio… Non si spiegherebbe, seguendo l’impostazione di Di Pietro, la telefonata di ringraziamento a Gorrini dopo la restituzione».
Chiaro? Chiaro. Ma chi è questo Giancarlo Gorrini?
Travaglio lo descrive solo così: «Un assicuratore che conosceva Di Pietro», uno che «era con l’acqua alla gola e aveva passato quell’estate del ’94 alla ricerca di aiuto e, naturalmente, si era rivolto anche all’entourage di Berlusconi». Basta.
Non dice, Travaglio, che Gorrini fu l’uomo a cui Di Pietro scroccò cento milioni, una Mercedes sottocosto poi rivenduta, pratiche legali per la moglie, ombrelli, agende, penne e cartolame, stock di calzettoni al ginocchio, viaggi in jet privato, infine un impiego per il figlio Cristiano.
E non lo diciamo solo noi, è a sentenza alle pagine 151 e 152:
«E’ indubbio che i fatti raccontati da Gorrini si erano radicalmente verificati», ossia «la prestazione di attività lavorativa di Cristiano Di Pietro a favore della Maa, l’assegnazione di alcune cause a Susanna Mazzoleni da parte della Maa, l’erogazione di un prestito a Di Pietro, la cessione a Di Pietro di un’autovettura recuperata dalla Maa e trasformata da Di Pietro stesso in prestito».
Ecco, appunto, e la famosa Mercedes? Travaglio la racconta ai poveri grillini in questo modo:
«Di Pietro aveva fuso la sua automobile, una Ritmo, e Rocca gli aveva dato una Mercedes usata di quelle che stavano lì nei magazzini, nei parcheggi dell’assicurazione e che poi Di Pietro aveva utilizzato per un certo periodo e poi l’aveva venduta al suo avvocato».
Allora. Anzitutto non era una Fiat Ritmo, ma una Fiat Regata; poi non la rivendette «al suo avvocato», ma all’amico Giuseppe Lucibello che all’occorrenza era anche avvocato, ma non il suo; poi non gliela diede Rocca, ma pure questa Gorrini; la «Mercedes che stava lì nei magazzini», poi, era solamente una Mercedes 300 Ce blu notte di poco tempo prima (sessantasette milioni di listino) a margine di una tresca che la magistratura, nella citata sentenza, ha messo come segue.
Pagina 153: «Di Pietro vende sostanzialmente un’auto che non gli appartiene, trattenendo i soldi»… Di Pietro vendette la Mercedes a Lucibello… con ogni probabilità non al prezzo di favore a lui accordato, cioè venti milioni, ma al reale valore di mercato, ovvero cinquanta milioni… ciò che in origine era un’iniziativa per l’acquisizione a buon prezzo di un’autovettura, diviene, senza soluzione di continuità, un’operazione per l’acquisizione a titolo di prestito della somma conseguita dalla vendita dell’auto medesima… Di Pietro cercò di occultare il prezzo reale dell’auto».
Ma tutte queste cose il grillino medio – in sostanza quel target travagliesco che all’epoca dei fatti era ancora poppante – non le deve sapere. Se lo dice Travaglio, allora sarà vero.
Poi Di Pietro decise di entrare in politica, a un certo punto. Ecco il racconto di Travaglio:
«Di Pietro dice no, dice che non intende fare politica subito, perché ha appena smesso di fare il magistrato e comunque, se la facesse, non la farebbe in un partito già esistente, né tantomeno nel partito di colui, Berlusconi, che lui stesso ha appena incriminato per corruzione della Guardia di Finanza e quindi da questo momento Berlusconi smette di difendere pubblicamente Di Pietro e i suoi giornali e le sue televisioni cominciano a massacrarlo, fino a quando, con opportune denunce portate o fatte portare, si riesce a attivare una serie innumerevole di processi contro Di Pietro a Brescia che dureranno due anni e terranno Di Pietro per due anni fuori dalla politica: perché? Perché è evidente che uno che ha detto che non bisogna fare politica da indagati, essendo indagato lui, non può certamente contraddirsi e conseguentemente aspetterà di essere prosciolto da tutto per poter entrare in politica dopo le elezioni del 96, quelle vinte da Prodi»
Ora: lo sanno anche i sassi che Di Pietro entrò in politica – o meglio lasciò la magistratura – perché sennò i citati episodi riguardanti Gorrini (più altri che non ho neppure citato) lo avrebbero sicuramente sputtanato e fatto travolgere, quantomeno, da una sanzione del Csm. Lo sanno anche i sassi, ma Travaglio e Di Pietro fanno finta di nulla. Dalla citata sentenza che è – ricordiamo ancora – passata in giudicato, pagine 154 e 156:
«I fatti si erano realmente svolti ed alcuni rivestivano caratteri di dubbia correttezza, se visti secondo la prospettiva della condotta che si richiede a un magistrato», trattasi insomma di «aspetti di indubbia discutibilità».
Pagine 151 e 152: Questi episodi «rischiavano di prospettare agli inquirenti un sistematico ricorso di Di Pietro ai favori di Giancarlo Gorrini, il quale, peraltro, alla data del novembre 1994 risultava già condannato per appropriazione indebita». «Ne viene fuori un quadro negativo del’immagine di Di Pietro… fatti specifici che oggettivamente potevano presentare connotati di indubbia rilevanza disciplinare».
Pag. 152: «In conclusione può quindi ritenersi che Di Pietro era particolarmente attratto fin dal maggio del ’94 da investiture politiche. La prova sul punto è fornita proprio da quella primitiva disponibilità espressa da Di Pietro rispetto alla proposta di Berlusconi, rivelandosi ciò non solo da dichiarazioni dell’imputato Previti, ma anche dalla circostanza dell’incontro a Roma. Un incontro personale, poco compatibile con un rifiuto indiscriminato e generalizzato a qualsiasi incarico politico… D’altronde, Di Pietro manifestò al collega Davigo, che aveva ricevuto per parte sua un’offerta per il ministero di Grazia e Giustizia, un’indecisione in merito alla proposta del Polo, significando, perciò, una disponibilità concreta ad accettare. Ma Di Pietro era interessato, in alternativa, anche all’assunzione di autorevoli e prestigiosi incarichi istituzionali, e infatti di una tale possibilità parla con Previti nel corso del precitato incontro… Una volta conosciuti da parte dei suoi colleghi gli interessi politici che andava coltivando e rafforzando, questi avrebbero potuto sospettarlo di duplicità per non aver condotto con la sua tradizionale veemenza la discussione e la decisione contro Berlusconi. Insomma, un’immediata partecipazione di Di Pietro al procuratore e agli altri colleghi delle prospettive che gli si aprivano… avrebbe potuto inquinare quella sua indiscussa leadership all’interno e all’esterno del pool, con consequenziali ripercussioni nell’immagine esterna, e avrebbe potuto indurre i colleghi a renderlo sempre meno partecipe dell’attività giudiziaria in vista di un suo preannunciato abbandono».
Pagina 150: «Il complesso della narrazione era tale da creare una qualche preoccupazione in tal senso in Di Pietro, e ciò anche per alcuni risvolti non certo trasparenti che a quelle vicende si erano accompagnati».
Tutta roba che secondo Di Pietro e Travaglio non si deve sapere: questa sentenza non l’hanno mai citata in vita loro. Anche se è l’unica che conta.
Il ventriloquo, Travaglio, nel suo intervento rtivolto ai grillini non fa che citare se stesso e lo stesso Di Pietro: la scia di balle e di omissioni, del resto, «è quello che ci aveva raccontato Di Pietro per il libro “Mani Pulite”», ha detto, e del resto «è probabile che lo ripubblicheremo e che lo distribuiremo insieme a Il Fatto». Il che spiega perché Di Pietro non farà mai un proprio organo di partito: ce l’ha già.
Se volete un altro esempio di quanto sia ballista Di Pietro – vabbeh, io ci ho scritto un libro intero – si torni al 25 marzo 2002, quando andò al Liceo Scientifico «Vittorio Veneto» di Milano a raccontare se stesso e l’inchiesta Mani pulite. Ecco, quel giorno un paio di studenti gli fece sempre la solita maledettissima domanda: perché ha lasciato la toga per fare politica? E lui, oltretutto con postura pedagogica:
«Vedete, nella formulazione stessa di questa domanda è implicita la manipolazione dell’informazione a cui tutti voi, vostro malgrado, siete stati e siete soggetti. Perché io non ho lasciato la toga per fare politica. Ho lasciato la toga per difendermi. E solo dopo essere stato assolto da ciascuna delle 27 accuse che erano state mosse a mio carico ho deciso di entrare in politica».
Ecco. Dopo una premessa falsa – quando lasciò la toga, infatti, non doveva difendersi da niente, le inchieste furono tutte successive, la prima fu sei mesi dopo che aveva lasciato – aveva nascosto loro che ben prima dell’ultima «assoluzione», che fu nel 1999, aveva già fatto il ministro con Prodi, era stato eletto al Senato, aveva fondato un gruppo parlamentare e di passaggio anche un partito, il suo. Nascondeva questo e dava di manipolati a dei ragazzi che gli avevano fatto una domanda normale. E’ la stessa tecnica che usa Travaglio coi grillini e coi vari fan amici suoi.
***
Update. Per documentazione, riporto un altro passo della sentenza che integra uno sovrastante. Copiato a mano, non è in rete come tutto il resto.
pag 169 – 180: «In conclusione può quindi ritenersi che Di Pietro era particolarmente attratto fin dal maggio del ’94 da investiture politiche. La prova sul punto è fornita proprio da quella primitiva disponibilità espressa da Di Pietro rispetto alla proposta di Berlusconi, rivelandosi ciò non solo da dichiarazioni dell’imputato Previti, ma anche dalla circostanza dell’incontro a Roma.
Un incontro personale, poco compatibile con un rifiuto indiscriminato e generalizzato a qualsiasi incarico politico, ben collima con la prospettazione dei fatti da parte di Previti. D’altronde, Di Pietro manifestò al collega Davigo, che aveva ricevuto per parte sua un’offerta per il ministero di Grazia e Giustizia, un’indecisione in merito alla proposta del Polo, significando, perciò, una disponibilità concreta ad accettare.
Ma Di Pietro era interessato, in alternativa, anche all’assunzione di autorevoli e prestigiosi incarichi istituzionali, e infatti di una tale possibilità parla con Previti nel corso del precitato incontro. Accetta di buon grado l’offerta del collega Ghitti, prima giudice delle indagini preliminari di Milano e già dalla seconda metà del 1994 componente del Consiglio superiore della magistratura, di verificare la disponibilità di incarichi, anche all’estero, per un collocamento fuori ruolo della magistratura. Altri eventi si allineano con una strategia personale della parte offesa di uscire dalla magistratura.
La ferma presa di posizione di Di Pietro sul provvedimento varato dal ministro Biondi in materia di custodia cautelare e le proposte avanzate al convegno di Cernobbio sui modi per definire Tangentopoli evidenziano chiaramente questo sempre più marcato orientamento di Di Pietro ad assumere iniziative e posizioni più confacenti a un esponente politico che a un magistrato. In definitiva, Di Pietro sente su di sé il ruolo assunto nell’opinione pubblica, ruolo che va oltre i limiti della stretta funzione giudiziaria, essendo sempre più forte la sua rappresentazione, anche attraverso la stampa, come quella di un leader; ha piena consapevolezza del vasto consenso popolare che riscuote la sua azione e di quanto sia ascoltata la sua voce, in qualsiasi ambiente manifesti il proprio pensiero, soprattutto quando affronta i temi della corruzione: ha coscienza che qualsivoglia tentativo di aggressione nei confronti della sua correttezza professionale avrebbe dovuto fare i conti, innanzitutto, con i movimenti di piazza, sicché sarebbe stato destinato al fallimento.
Questi presupposti rendevano legittime le aspirazioni di Di Pietro a un ruolo corrispondente al consenso popolare, e un tale ruolo non poteva che essere politico, ovvero un prestigioso incarico nell’ambito della pubblica amministrazione. Non è un caso che la stampa dibattesse sulla sua candidatura in occasione delle competizioni elettorali di quel periodo, come non è un caso che lo stesso Di Pietro fosse vaticinato come futuro leader della destra. I nuovi interessi che si affacciavano all’orizzonte del magistrato, resi concreti da quei fattori storici di indubbia verità, acquisivano gradualmente corpo, in una sorta di escalation senza soluzione di continuità;è quindi particolarmente arduo separare una condotta antecedente alle preannunciate dimissioni del 6 dicembre da una condotta a queste successiva.
Pertanto aumentano progressivamente i contatti, i colloqui e gli incontri di di Pietro con gli esponenti di tutte le forze politiche, le collaborazioni a settimanali e quotidiani, lanciando il suo programma del partito degli onesti, le iniziative per la costituzione di un nuovo movimento politico, che gran risalto ottiene sulla stampa, la successiva decisione di ritardare l’impegno attivo nella politica fino alla definizione delle inchieste condotte dal pubblico ministero Salamone, infine l’accettazione dell’incarico governativo di ministro dei Lavori pubblici nella compagine dell’Ulivo. Contrafforte di questa scelta è la presa di distanza della parte offesa dalla sua precedente attività giudiziaria.
Il riferimento è al contenuto del colloquio intercorso tra Silvio Berlusconi e Di Pietro nel febbraio 1995. In particolare, nel corso della trasmissione televisiva «Tempo reale», Silvio Berlusconi dichiarò che in occasione di quell’incontro Di Pietro gli aveva manifestato il suo dissenso rispetto alla decisione, assunta dai componenti del pool della Procura di Milano, di inviargli l’invito a comparire notificato nel novembre 1994. Immediata fu la reazione del procuratore Borrelli, che contattò telefonicamente Di Pietro per un chiarimento sul punto e per l’assicurazione di una futura smentita, che in effetti ci fu nei giorni successivi.
La vicenda, però, non esaurì i suoi strascichi perché da un lato ci fu un inasprimento dei rapporti tra Di Pietro e gli altri componenti del pool, a cui si cercò di porre riparo con una cena pacificatrice che però non risolse tutti i dubbi sui reali contenuti del colloquio Di Pietro / Berlusconi, dall’altro ci fu l’interruzione dei rapporti tra Di Pietro e i maggiori rappresentanti del Polo, fino a quel momento idilliaci. A ogni buon conto in sede processuale Antonio Di Pietro ha smentito di aver detto a Silvio Berlusconi quanto da lui riferito, perché, sostiene, il colloquio ebbe a oggetto soltanto il suo eventuale schieramento politico. In ordine all’episodio si impongono alcune brevi osservazioni. Preliminare è la verifica dell’atteggiamento assunto da Di Pietro nel corso delle riunioni del pool finalizzate alla decisione se procedere o meno nei confronti del presidente del Consiglio Berlusconi nell’ambito delle indagini su fatti di corruzione ascritti al gruppo Fininvest.
Orbene, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi che Di Pietro fu uno dei principali sostenitori dell’idoneità degli elementi d’accusa raccolti nei confronti di Silvio Berlusconi, e non solo per iscriverlo nel registro degli indagati, ma anche per otenerne il rinvio a giudizio e la futura condanna. La questione era stata oggetto di alcune riunioni… Più precisamente nelle riunioni di maggior rilievo, svoltesi il 14 e il 18 novembre e precedute dalla distribuzione da parte di Di Pietro di un faldone contenente tutti gli atti riguardanti Berlusconi, si trattò sia la questione se vi fossero elementi per l’iscrizione (ma sulla bontà degli elementi raccolti per procedere a un’iscrizione non vi erano dubbi), sia le modalità procedurali da seguire.
In proposito Di Pietro, motore dell’azione perché meglio di tutti gli altri conosceva gli atti d’indagine, unitamente a Davigo, sosteneva che occorresse procedere, contestualmente all’iscrizione nel registro degli indagati, all’invio di un invito a comparire, dal momento che l’iscrizione nel registro non sarebbe rimasta segreta per molto tempo e la divulgazione anticipata della notizia avrebbe potuto pregiudicare l’inchiesta. Altri, come il procuratore aggiunto D’Ambrosio e il dottor Greco, erano più prudenti e ritenevano opportuno attendere (era in corso di dibattito, appunto, la legge finanziaria), preoccupati per le fughe di notizie e le scontate accuse di strumentalizzazioni.
Alla fine Di Pietro riuscì a convincere tutti i componenti del pool di procedere all’iscrizione e all’invio dell’invito a comparire, perorando con vivacità la propria tesi e comprovando, in una sorta di interrogatorio simulato, la fondatezza dell’accusa. Si decise anche che all’interrogatorio di Berlusconi avrebbero proceduto Borrelli, Di Pietro, Davigo, e Colombo, mentre Greco avrebbe interrogato contemporaneamente l’avv. Berruti. In ogni caso era scontato, hanno concordemente riferito i testi, che il rappresentante dell’accusa in un eventuale dibattimento sarebbe stato Di Pietro.
I fatti che seguirono appartengono alla storia nazionale più recente: il 21 novembre Silvio Berlusconi venne iscritto quale indagato e il 22 novembre gli fu notificato l’invito a comparire. Ciò posto, la valutazione successiva è la verosimiglianza delle affermazioni di Berlusconi alla precitata trasmissione televisiva. Osserva il Tribunale che risultano acquisti al dibattimento elementi univocamente convergenti nel senso di una veridicità di quanto dichiarato da Berlusconi. Intanto gli stessi colleghi di Di Pietro non hanno mai ricevuto da questi una risposta satisfattiva, nonostante le pressanti richieste di chiarire una volta per tutte il reale contenuto di quel colloquio e, soprattutto, se aveese mai detto di non aver condiviso la scelta della Procura di inviare a Silvio Berlusconi l’invito a comparire.
Si rammenti che la cena organizzata, presso l’abitazione del dottor Colombo, nella primavera del 1995, al fine specifico di chiarire la situazione creatasi dopo quelle dichiarazioni pubbliche, non sortì l’effetto sperato perché non vennero sciolti i dubbi iniziali e rimase il sospetto della veridicità di quanto affermato da Berlusconi. E proprio questo difetto di chiarezza di Di Pietro sul punto avvalora indiziariamente quanto sostenuto, in altre sedi, da Silvio Berlusconi. In secondo luogo, il teste Cossiga ha riferito anch’egli di aver percepito, da ciò che gli disse di Pietro nel corso di un colloquio avuto nel gennaio del 1995, un suo disagio a condurre l’interrogatorio di Berlusconi, e comunque che non aveva gradito che fosse stato designato a condurre il precitato interrogatorio.
La deposizione del senatore Cossiga conferma, a livello indiziario, un atteggiamento di Di Pietro di allontanare da sé, subito dopo l’uscita dal pool e nella fase transitoria prima di entrare operativamente nell’attività politica, l’idea che l’invito a comparire fosse da attribuire principalmente a una sua iniziativa. E’ vero che l’interessato ha in sostanza smentito quanto detto dal teste, ma la risposta è incerta e vaga ( ci si limita a contestare il corretto uso del termine “costrizione“ usato da Cossiga), e comunque vale ribadire la minor valenza probatoria di queste dichiarazioni, sia perché provenienti da un soggetto citato ai sensi dell’art. 210 c.p.p., e perciò valutabili secondo il criterio di cui all’art. 192 c. 3 c. p. p., sia e soprattutto perché il dichiarante ha rifiutato di sottoporsi all’esame, con ciò sottraendosi al contraddittorio processuale delle parti e del giudice… In conclusione, gli elementi indicati sono univoci per ritenere che in quel’occasione Di Pietro manifestò a Silvio Berlusconi una sorta di strisciante dissenso o, comunque, di non piena adesione a quell’atto giudiziario che tante polemiche aveva suscitato.
Si può certo ipotizzare un’accentuata enfatizzazione dell’episodio da parte dell’interlocutore Berlusconi, ma le risultanze probatorie dibattimentali non consentono di negare il fatto in radice. E la motivazione del magistrato per l’assunzione di un tale attegiamento, chiaramente in antinomia con la realtà dei fatti, è spiegabile proprio nell’ambito di quel crescente attivismo politico, di cui si è detto, e della ricerca iniziale delle probabili alleanze. Sulla base delle risultanze dibattimentali sopra analizzate, può legittimamente e fondatamente affermarsi che Di Pietro, vuoi per la stanchezza fisica e psicologica maturata a causa deglia anni di intenso lavoro e degli attacchi ormai ripetuti nei suoi confronti, vuoi soprattutto per un crescente desiderio di divenire soggetto protagonista della vita politica o, quanto meno, di acquisire iniziali posizioni verticistiche di organi istituzionali (posizioni che, comunque, per la delicatezza del ruolo e delle funzioni avrebbero richiesto il beneplacito delle forze politiche governanti), aveva maturato nell’autunno del 1994 il preciso proposito di abbandonare l’attività giudiziaria all’interno del pool, se non addirittura la magistratura. E si trattava di un proposito maturato, nella prospettiva professionale dell’interessato, già da qualche tempo, e precisamente dalla primavera del 1994.
Innanzitutto è la moglie di Di Pietro a collocare nella primavera del 1994 i primi discorsi del marito sull’uscita da quelle indagini appena dopo la fine del processo Enimont, e la teste conferma quale causa di questa decisione tutte le motivazioni in vario modo esposte da Di Pietro (stanchezza, pesante coinvolgimento della famiglia e così via). Ma ancor più significativo risulta in proposito il colloquio avvenuto nell’aprile del 1994 tra Di Pietro e Ghitti, all’epoca ancor giudice per le indagini preliminari di Milano, allorquando al preannuncio di Ghitti di una sua possibila canditatura per il Consiglio superiore della magistratura, Di Pietro gli consigliò di accettare, essendo anch’egli intenzionato ad andarsene dopo il processo Enimont.
Di Pietro giustificò questa sua futura scelta con la fine di Mani pulite, intendendo dire, come più chiaramente in seguito si esprimerà con i colleghi del pool, che la fine dell’inchiesta era conseguente alla conclusione del processo (Enimont, ovviamente) che aveva visto tra gli imputati tutti i maggiori rappresentanti politici di quella che ormai, con linguaggio giornalistico, è denominata Prima Reppublica. Questi concetti saranno ribaditi nella riunione del 30 novembre o del 1 dicembre 1994, presenti Borrelli, Davigo, Colombo e Greco, nel corso della quale verrà ufficializzata la decisione delle dimissioni anche agli altri componenti del pool, e nell’occasione risulterà vana la dura presa di posizione di Borrelli nei confronti di Di Pietro per convincerlo a desistere da quell’intenzione. In quella riunione Di Pietro riaffermò che Mani pulite era finita, l’acqua non arrivava più al mulino, intendendo l’esaurimento delle fonti informative, e che occorreva scendere da cavallo prima di essere disarcionati, addirittura invitando tutti i colleghi ad assumere decisioni analoghe alla sua. Quest’ultima affermazione, poi, rende palese il desiderio di lasciare l’incarico giudiziario nel momento di massima popolarità, e ciò non poteva che essere funzionale e strumentale a un successivo sfuttamento di questa popolarità che avrebbe raggiunto l’apice con la requisitoria del processo Enimont.
L’intento manifestato già ad aprile trova un riscontro nell’accelerazione che Di Pietro impresse al processo Enimont nel periodo immediatamente successivo, invitando anche Ghitti a una sollecita fissazione dell’udienza preliminare. Certo, la deposizione del teste Ghitti non risolve il nodo se Di Pietro all’epoca avesse maturato l’idea di uscire dall’inchiesta oppure dalla magistratura. Il teste ha affermato più volte che con lui si parlò sempre di uscire dall’inchiesta, tanto che in seguito si interesò per individuare un incarico fuori ruolo, e questa circonstanza era incompatibile con una decisione di dimettersi all’ordine giudiziario. Tanto che, dice sempre il teste, quando il 6 dicembre Di Pietro gli mostrò le missive indirizzate al procuratore, lui gli fece presente che l’espressione «lascio l’ordine giudiziario» non corrispondeva alla sua effetiva volontà, ma la replica del collega fu che ormai quelle erano le lettere e con quel contenuto le avrebbe trasmesse. Ad aviso del Collegio può ritenersi che da un’iniziale ipotesi di semplice dimissione dell’incarico all’interno del pool Di Pietro abbia via via sempre coltivato l’ipotesi di uscire dalla magistratura.
D’altronde la concretezza di eventuali incarichi politici o istituzionali si consolida successivamente (l’incontro con Previti e Silvio Berlusconi è del maggio 1994), e i motivi di insofferenza e disagio si accentuano nell’autunno caldo del 1994…Unico serio elemento che cartolarmente contrasterebbe con l’anticipazione ad aprile della decisione di dimettersi deriva dalla posizione assunta da Di Pietro nell’ambito delle riunioni del pool in cui si trattò della posizione di Silvio Berlusconi nelle indagini sulla Guardia di Finanza. Si è acclarato in precedenza che gli univoci elementi probatori sul punto hanno dimostrato che Di Pietro nell’occasione si presentò come l’assertore più convinto della bontà del materiale d’accusa a carico di Berlusconi (materiale, peraltro, da lui stesso organicamente raccolto), e il più determinato e il più irruento nel sostenere non solo che si sarebbe ottenuto il rinvio a giudizio, ma anche una futura vittoria in sede dibattimentale, nella quale lui si riprometteva di sostenere il ruolo dell’accusa. Tuttavia un siffatto atteggiamento non si spiega con le ormai prossime dimissioni che, in quel periodo (seconda metà del mese di novembre), dovevano essere già ampiamente maturate e in fase di imminente attuazione (era prossima la requisitoria, e quindi la sentenza Enimont). Non può disconoscersi che questo è un argomento di forte impatto, ma è ugualmente incontestabile, per l’estrema serietà delle fonti, che la decisione delle dimissioni era ben anteriore.
L’unica spiegazione che il Collegio ritiene di poter proporre, a fronte di tale insanabile contraddizione dei dati processuali, consiste nel timore di Di Pietro che, una volta conosciuti da parte dei suoi colleghi gli interessi politici che andava coltivando e rafforzando, questi avrebbero potuto sospettarlo di duplicità per non aver condotto con la sua tradizionale veemenza la discussione e la decisione contro Berlusconi. Insomma,un’immediata partecipazione di Di Pietro al procuratore e agli altri colleghi delle prospettive che gli si aprivano, dei contatti e colloqui politici di quel lungo periodo della seconda metà del 1994 a partire dall’incontro del maggio, delle riflessioni che portava avanti circa la necessità di un suo nuovo e differente impegno in altra sede (politica propriamente ovvero istituzionale), avrebbe potuto inquinare quella sua indiscussa leadership all’interno e all’esterno del pool, con consequenziali ripercussioni nell’immagine esterna, e avrebbe potuto indurre i colleghi a renderlo sempre meno partecipe dell’attività giudiziaria in vista di un suo preannunciato abbandono delle funzioni inquirenti».