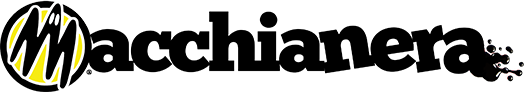Il processo ad Annamaria Franzoni è stato mediaticamente anomalo, nessun dubbio, ma di tutti i processi mediaticamente anomali è forse il meno peggio che ci è capitato da una quindicina d’anni a questa parte.
Dalla morte del bambino, Samuele, sono passati 63 mesi, e ormai conosciamo Cogne meglio del campo di battaglia di Waterloo: un insignificante colpo di scena dopo l’altro, una perizia dopo l’altra, un avvocato dopo l’altro, soprattutto un’intervista dopo l’altra.
E’ più che evidente che la pressione mediatica ha creato un’aspettativa tremenda, tanto che, dopo cinque anni, ciascuno ha voluto dire la sua come se i giudizi di tribunale avessero contato relativamente, come il se il vero processo fosse appunto quello giornalistico fatto di perizie e indizi propri, fatto di proscioglimenti e condanne decretati dall’Auditel.
E’ pure evidente che questo ha coinciso con la deliberata strategia difensiva di Annamaria Franzoni, qualcosa tra il pensato e l’istintivo: un invocare il pubblico per gridare la propria innocenza davanti a tutti, spesso lasciando i magistrati in fondo alla lista. Non di rado l’imputata ha disertato le udienze ma non le interviste, talvolta ha risposto evasivamente in aula ma in serata non ha lesinato particolari all’intervistatore. Carlo Taormina, per molto tempo, è stato l’avvocato ideale proprio perchè abile oltretutto in sede extraprocessuale, e la famiglia a un certo punto organizzò addirittura un ufficio stampa. Un continuo Cogne e fotti.
Sono cose che negli Stati Uniti succedono spesso: eppure gli ultimi che avrebbero dovuto preoccuparsene, da noi, sono i magistrati. Ovvio che il caso mediatico catalizzasse polemiche varie tra giornalisti e opinionisti e garanti vari, riassumibili essenzialmente nel fatto che Bruno Vespa abbia fatto sfracelli di ascolti (più di altri) e non abbia più mollato l’osso, contribuendo a una divisione tra innocentisti e colpevolisti che ora non ci interessa giudicare.
Ma che cosa poteva realmente importare, ai magistrati, del processo mediatico? Loro conducevano quello vero, le telecamere hanno lambito l’aula dibattimentale ma in fin dei conti ne sono restate fuori, fuori dall’istruttoria vera, dal processo vero: i magistrati, essi soli, conoscevano la sostanza penale che unicamente contava: nessun inferno mediatico, là fuori, avrebbe dovuto toccarli, anche perchè l’essere irreprensibili è parte essenziale del loro ruolo.
Eppure sono proprio loro, all’apparenza, ad aver patito il processo mediatico. Nella requisitoria finale, il pubblico ministero si è proposto quasi come un didatta e ha ripercorso la dinamica dell’omicidio con uno stile caro a tv e giornali: la sua determinazione nel distruggere l’imputato mediatico, quasi più di quello processuale, era evidente a tutti.
Qualche giorno prima, invece, era stato il sostituto procuratore generale a fare una requisitoria direttamente contro tv e giornali, colpevoli di aver celebrato un processo a latere e di aver affidato le sentenze a Paolo Crepet e Barbara Palombelli. Come se i magistrati ne fossero usciti comunque disturbati, come se il processo mediatico li avesse lentamente rosicchiati: sembrava quasi che reclamassero una par condicio mediatica, anzichè stringersi serenamente attorno alle sole certezze probatorie, le uniche che contano, quelle che nessun giornalista potrà mai trasformare in sentenza.
La comica, a margine del processo di Cogne, è che l’Unità è riuscita a scrivere questo: “Gli ultimi lasciti del berlusconismo sono la tv giudiziaria e la giustizia televisiva”. Cioè: anche il bailamme di Cogne sarebbe colpa di Berlusconi. Il problema della giustizia televisiva, ossia, sarebbe quello delle trasmissioni giornalistiche che si sono occupate del caso Franzoni, come se le telecamere deformassero i processi dall’esterno dell’aula e non li deformassero, invece, dal suo interno, come è stato fatto ripetutamente negli anni Novanta mentre l’Unità applaudiva.
Un giorno in pretura, per cominciare, è una trasmissione che esiste solo in Italia. Il primo a indossare la toga in tv, credendo di scherzare, era stato Giuliano Ferrara ne L’istruttoria, Raitre, 1987. Nell’introdurre il libro “Il circo mediatico giudiziario” di Daniel Soulez Larivière, nel 1993, Ferrara la mise così: “Mi accadde di indossare una toga e di fare una dozzina di processi televisivi. Ma io scherzavo. Anzi, credevo di scherzare e ora non mi resta che chiedere perdono. Perchè sapete tutti com’è andata a finire: le Tv e i giornali la toga l’hanno indossata sul serio. Mi sono spesso domandato, quando ho visto Di Pietro in tv e prima di lui i processi in pretura, quando ho visto il gioco della vittima e del carneficie in azione dispiegata, come potessi non sputarmi da solo in un occhio. Io scherzavo, ma quel travestimento era una grottesca premonizione”.
Il resto lo sappiamo, o forse dovremmo risaperlo.
Il 7 e 14 febbraio 1993 Un giorno in pretura mandò in onda il primo Di Pietro piazzato su un palchetto più alto, con stacco finale sulle lacrime del socialista Walter Armanini; seguirà poi il celebre processo Cusani, sintassi delle inquadrature che stravolse la grammatica processuale, sfilata degli untori, scenette e teatrini, finte litigate, ridondanze pedagogiche verso le telecamere.
Qualcosa che è vietato e quindi non esiste in Austria, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania, Canada, Inghilterra, Galles e praticamente tutto l’Occidente. Negli Stati Uniti i processi si possono trasmettere, purchè lo siano integralmente (ci sono canali dedicati) e un imputato può fare il ricorso nel caso sostenga che una trasmissione non gli ha portato sufficiente rispetto.
Da noi, per anni, le telecamere “dentro” i processi hanno invece trasformato le aule in teatri giudiziari dove l’imputato veniva triturato comunque, e dove ogni attore era portato a snaturarsi. Avremmo dovuto strillare allora.
Ora, tutto quel che accade fuori dell’aula, tra plastici e mestoli e ciabatte, può piacere o anche fare schifo: ma rientra in qualche modo in una legittimità giornalistica, nelle regole di una grande circo che ormai c’è e ormai non ci abbandonerà più.
I giornalisti continueranno a scegliere in che misura essere seri o fare i pagliacci: è il loro lavoro.
Ma i magistrati, almeno loro, potrebbero resterne fuori e non fare i pagliacci: è il loro lavoro.