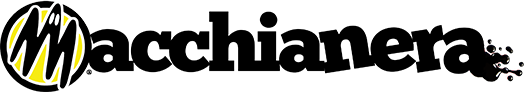La prima scena è questa: al ristorante del lido di Macchiatonda, a Capalbio, praticamente in spiaggia, alle 13.30 di domenica scorsa eccoti giungere Sir Henry John Woodcock con la moglie. Indossa un giubbotto rosso (lui adora il rosso) e un cappellino da baseball ma soprattutto si porta dietro lo sguardo autoriflesso di chi si sente al centro dell’inquadratura.
Eppure è come se a Capalbio (mai visto prima, a Capalbio) qualcosa stesse andando storto: nessuno infatti lo riconosce, nessuno gli chiede autografi, ha lo sguardo mesto; ma questa potrebbe essere solo una malignità dei testimoni oculari. Ci sono, tra questi, otto habitué riuniti in tavolata, sinchè uno si rivolge discretamente a Woodstock: “Dottore, ascolti, vorrei farle una foto col telefonino, se gliela faccio poi me la ricompra?”.
Il bello è che la foto poi gliela fa, o meglio, Woodcock se la fa fare.
Gli habitué riferiscono che peraltro gli ha fatto tornare il buon umore, l’hanno visto accendersi come un televisore. Malignità.
La seconda scena è quest’altra, anzi no, non è una scena, è una leggenda mediatica: dice che tanti giornalisti non parlano male di Woodcock perchè lui ha in mano cose terribili anche su di loro, tipo intercettazioni, cose sessuali, ecco perchè i quotidiani lo lasciano stare, ecco perchè non dedicano ampi servizi alla sua moto e al cane e alla bistecca di vitella tagliata grossa, come piace a lui.
E dire che ai grandi quotidiani basterebbe chiedere, lasciare un messaggio al macellaio di via Pretoria, Vincenzo, ex ultrà del Potenza, amicone del magistrato. Al cronista e al fotografo di Vanity Fair, testata dal nome azzeccatissimo, in fondo è bastato chiedere talchè la settimana scorsa il riservato Woodcock ha spalancato loro le porte: immagini posatissime, lo sguardo dritto nell’obiettivo, sulla scrivania le opere complete di George Orwell. Proprio lui, proprio quello.
Non è vero che Woodcock non parli: basta non riportare i virgolettati. E’ gentile. Senza mandare un fotografo, tuttavia, ci sono già in giro un sacco di foto: sulla copertina del penultimo Dipiù compaiono per esempio Woodcock e signora (discreto magistrato anche lei) e nelle pagine interne eccoti Woodcock in barca, in jeans, in cravatta, in toga, con la mamma, con il cane, col padre, senza padre, sulla slitta. Tutte foto private, chissà chi le avrà date a Dipiù affinchè titolasse “Woodcock, la carriera e l’inchiesta dell’uomo che sta affascinando l’Italia”. Lui no.
Anche le foto di Panorama, dove lo si vede poppante, e a sei anni, e a quattordici, poi in Croazia, poi ancora col cane, non le ha mica date lui. Le hanno fornite alcune agenzie di stampa. E chi le ha date alle agenzie? Lui no.
Forse il macellaio.
Ma non c’è da preoccuparsi, si dirà: sono solo iconografie, corredi ad articoli dove spiegare che “Woodcock è diventato una celebrità, proprio come Antonio Di Pietro, anzi diciamo la verità, è più celebrità di Di Pietro, lui ha il fascino della stella della Tv, nel mondo dello spettacolo si parlerebbe di lui come un sex symbol”.
Va bene. Ma la sua inchiesta? “Anche Woodcock, però, è umano. Sicuramente va a fare la spesa dal macellaio e dal droghiere, non rinuncia mai a ai formaggini”.
Sì. Ma l’inchiesta? “Mangia arance e banane, Vito Lorusso gli prepara sempre un antipasto con ricotta, salame, mozzarella e caciocavallo”.
(Secondo Dipiù, tra parentesi, Woodcock mangia strascinati coi peperoni, mentre secondo Panorama, invece, pasta con fagioli e cozze, mentre secondo Vanity Fair, ancora, gli strascinati li mangia la sera perchè a mezzogiorno agogna pasta e ceci: non ci sono più i cronisti giudiziari di una volta.)
A proposito, l’inchiesta? Finalmente, su Dipiù, compare il primo e il solo virgolettato di Woodcock: “Noi che viviamo in tribunale siamo uomini fortunati, perchè, senza pagare il biglietto, abbiamo un posto in prima fila nel teatro della vita”.
Noi fortunati. Biglietto. Prima fila. Certo. The show must go on. Vanity Fair o Repubblica fa lo stesso, condannati o assolti anche.
La gente acclama Woodcock, il magistrato dell’era televisiva, anzi, “il primo magistrato anticonformista, menefreghista, antiperbenista arrivato nell’Italia post Mani pulite”, precisa Panorama. A Studio Aperto, su Italiauno, Woodcock ieri l’altro si è prestato a un giochino di finte intercettazioni dove ha confessato che da giovane voleva fare lo stilista.
Beh, ce l’ha fatta, è inopinatamente uno stilista del diritto come moltissimi gli riconoscono, tribunali giudicanti compresi. Le sue inchieste più note – mi ripeto – sono state una collezione di incompetenze territoriali e nomi altisonanti assolti, ministri prosciolti, richieste d’arresto ingiustificate, e poi archiviazioni, bocciature per il 70 per cento dei suoi ricorsi, più gli ormai celebri 7 milioni e passa euro spesi per tre anni di intercettazioni.
Persino l’attuale sindaco di Potenza, Vito Santarsiero, uno della Margherita, fu indagato da Woodcock nel 2004 e in linea teorica sta ancora aspettando l’interrogatorio. L’unica richiesta formale, sinora, l’ha fatta lui: ha chiesto indietro tutti i vigili urbani che da due anni e mezzo sono distaccati a sbobinare intercettazioni, fortunati anche loro, tutto il giorno in prima fila nel teatro della vita senza pagare il biglietto: quello lo paghiamo noi.
The show must go on. I succitati periodici informano che la sera, quando c’è Montalbano in Tv, Woodcock esce anzitempo dall’ufficio e corre a casa. Anche Distretto di Polizia lo appassiona moltissimo. Altre vite, altri teatri.
Se a Potenza sfileranno i vip, il mattino dopo, le ragazzine marineranno la scuola e s’attaccheranno all’inferriata del tribunale: altri teatri.
Sul comodino di Woodcock, informano pure, sono appoggiati libri di Salinger, Pasolini ed Erri e Luca. Ma a distinguere tra teatro e mediatico e teatro della vita, tra finzione e realtà, laddove la gente soffre veramente soprattutto quando tritata prima di essere sovente assolta, ecco, non starebbe male anche un bel tomo di Leonardo Sciascia.
Scriveva Scascia, nel 1986, sulla rivista Il giudice:
“Un giovane esce dall’Università con una laurea in giurisprudenza; si presenta ad un concorso; lo supera svolgendo temi inerenti astrattamente al diritto: e da quel momento entra nella sfera di un potere assolutamente indipendente da ogni altro che sia possibile conseguire attraverso un corso di uguale durata, attraverso un’uguale intelligenza e diligenza di studio, attraverso un concorso superato con uguale quantità di conoscenza dottrinaria e con uguale fatica. Ne viene il problema che un tale potere – il potere di giudicare i propri simili – non può e non deve essere vissuto come potere. La scelta della professione di giudicare dovrebbe avere radice nella repugnanza a giudicare, nel precetto di non giudicare; dovrebbe cioè consistere nell’accedere al giudicare come ad una dolorosa necessità, nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio.
Non da questo intendimento i più sono chiamati a scegliere la professione di giudicare. Tanti altri sono gli incentivi, e specialmente in un paese come il nostro. Ma il più pericoloso di tutti è il vagheggiare questo grande potere come un potere fine a se stesso o finalizzato ad altro che non sia quello della giustizia secondo lo spirito e la lettera della legge. L’innegabile crisi in cui versa l’amministrazione della giustizia deriva principalmente dal fatto che una parte della magistratura non riesce a introvertire il potere che le è assegnato, ad assumerlo come un dramma, a dibatterlo ciascuno nella propria coscienza, ma tende piuttosto ad estrovertirlo, ad esteriorizzarlo, a darne manifestazioni che sfiorano, o addirittura attuano, l’arbitrio. Quando i giudici godono il proprio potere invece di soffrirlo, la società che a quel potere li ha delegati, inevitabilmente è costretta a giudicarli”.
E noi davanti a Sciascia ci leviamo anche il cappello, il problema è che Woodcock ne indossa uno da baseball.