Una certa bellezza ruvida nell’ascoltarlo continuamente a mezza luce, con poca luce, fioca la luce nel giorno e nella notte. E non ci sono parole. Tanto io capisco soltanto il tatto delle tue mani e la canzone perduta e ritrovata. Certi gatti e certi uomini, svaniti in una nebbia o in una tappezzeria. Ma poi la strada inghiotte subito gli amanti. E se tu vuoi li puoi vedere laggiù, danzanti, che più che gente sembrano foulard. Poi è accaduto che una notte l’ho sognato. La mia faccia tra le sue mani, alcune parole sbrindellate piano, epperò affondate negli occhi, epperò forse parole di certe sue canzoni; ma io non le conoscevo, non le conoscevo, e dunque non sapevo se erano parole davvero, per me, o uno sputarmi addosso, di sotto i baffi, il già cantato altrove. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi e balordi. C’è in lei una specie di cielo, un’acqua di naufragio, un volo, dove giustifica e perdona tutta la vita mascalzona. E c’era una festa, tanta gente, la musica. Poi io, poi lui. Io, lui. Lui. Che m’invitava a ballare e quindi mi stringeva e giravamo avvolti dalla musica – che era la sua. Nelle braccia di Conte a ballare Conte. Fisarmoniche che andavano. Blue tango. Blue tango. Blue. Era una sua qualche canzone danzevole e fintamente allegra. Di quelle che ti strappano il cuore a morsi, se solo ti distrai. E gira, gira, gira, giravamo nella stanza aggrappati così. Lui era Conte e io ero io e stavo bene ma con dolore. Due sbalestrati e sbagliati a girare avvinghiati e caldi fra la gente inutile che faceva da sbiadito contorno. Due che si stringevano chissà perché – ma forte. Senza tempo e senza particolare gioia. C’era la disperazione delle ultime volte, anche se era la prima; e giravamo giravamo giravamo. Come la musica. Su antichi applausi a fior di pelle.
E quello che si pensava era poco chiaro. Certo ci si diceva di non smettere di ballare mai; per nessun motivo. Nel buio o nel chiarore. Ma sempre gioiosi e disperati, insieme, a sfrangiarsi in una vita assente o sfatta. Archi, fiati, scarpe lucide che battono e ancora battono sul pavimento. Del resto è sempre così che va, quando c’è lui di mezzo. Ti aggiusti i sogni e parti. Ti scoppia il petto, ti frusciano i pensieri e vuoi ballare e scappare via. Però insomma poi rimani. Tanto la scimmia della musica e il passo invisibile non finiscono mai, questo si sa. Na na na na na na naaaa. Nananananananaaaaaaaaa. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nananananannaaaaaaaaaa. La savana è vicina, molto vicina, troppo vicina. Non si sa perché le savane c’entrino, ma c’entrano anche loro, insieme a Parigi, che strano. E la tristezza compressa e dolce di una festa malriuscita acquista di senso nella solitudine e nel giallo ocra delle lampade, degli ottoni, delle occhiaie delle donne, dei cieli di bufera e delle bucce di banana. Vedi, ora è l’ora che bisogna andarsene. Lo so, lo so che questo non è cipria, è sorriso. Ed è l’ora, è l’ora, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è pioggia pioggia pioggia e Francia. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino. Cerchiamo un altro albergo, sì, e andiamoci però, a sbattere lì, così, i nostri corpi persi e nudi, feriti all’osso ma ancora vivi.
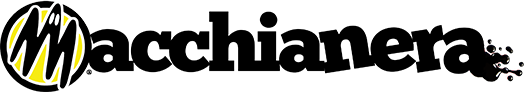
ahhhh…
ba’, vuoi mettere i prodigy?
e’ bellissimo..io mi commuovo solo a vedere il nome di paolo…